Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara e Museo Ebraico di Bologna in collaborazione con Comunità Ebraica di Bologna
Una mostra racconta la storia della comunità ebraica cittadina nei secoli del suo massimo splendore attraverso gli straordinari reperti di uno dei più ampi cimiteri ebraici medievali del mondo, quello rinvenuto qualche anno fa in Via Orfeo a Bologna, poco lontano dalle mura trecentesche
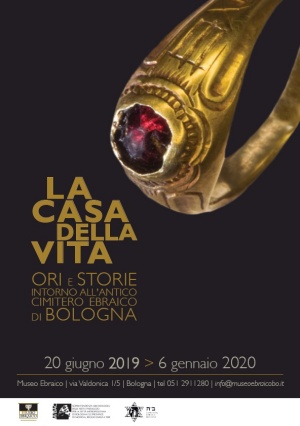 LA
CASA DELLA VITA
LA
CASA DELLA VITA
Ori e Storie intorno all’antico cimitero ebraico di Bologna
Dal 20 giugno 2019 al 6 gennaio 2020
nei seguenti orari: da domenica a giovedì dalle 10 alle 17.30, venerdì dalle 10
alle 15.30
(chiusa sabato e festività ebraiche)
entrata € 7.00 intero | € 5.00 ridotto
MEB - Museo Ebraico di Bologna
via Valdonica 1/5
Bologna (Italy)
info +39 051.2911280 -
info@museoebraicobo.it
DOMENICA 22 SETTEMBRE, alle ore 16,
in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio
Visita guidata alla mostra
La Casa della Vita. Ori e Storie intorno all’antico cimitero ebraico di Bologna
a cura dell'archeologa Valentina Di Stefano
La visita guidata è gratuita ma si paga l'ingresso ridotto al Museo di € 5.00
Max 30 partecipanti, prenotazione obbligatoria entro venerdì 20 settembre 2019 al tel. 051.2911280 oppure a info@museoebraicobo.it
“La Casa della Vita” o Beth ha-Chaim è uno dei modi con cui gli ebrei
indicano tradizionalmente il cimitero (Beth ha-kevaroth): “… ti ho
posto davanti la vita e la morte … scegli dunque la vita, onde tu viva, tu e la
tua progenie” Deuteronomio (30,19).
Tra il 2012 e il 2014, gli scavi stratigrafici estensivi condotti dalla
soprintendenza in Via Orfeo a Bologna, preventivi alla costruzione di un
complesso residenziale, hanno prodotto una delle scoperte archeologiche più
importanti degli ultimi decenni: il ritrovamento del “perduto” cimitero ebraico medievale
della città.
Nota alle fonti d'archivio e sopravvissuta nella consuetudine orale -quest'area
continua ad essere indicata come “Orto degli Ebrei” ben oltre la Bolla Papale
del 1569 che ne autorizzava la distruzione- l’area cimiteriale di Via Orfeo ha
restituito non solo centinaia di sepolture a inumazione perfettamente ordinate
in file parallele ma anche
straordinarie tracce di vita vissuta. Gioielli in oro di eccezionale fattura e
bellezza, pietre incise, oggetti in bronzo recuperati in più di quattrocento
sepolture, attestano la presenza a Bologna di una fiorente comunità
proficuamente inserita nel contesto urbano e sociale fino a quando l’emanazione
di due Bolle Papali la condanna ad abbandonare le città dello Stato Pontificio e
ad essere cancellata dalla memoria dei luoghi dove avevano vissuto e operato.
Questi reperti, finalmente visibili dopo anni di studi e restauri, sono i
protagonisti della mostra "La Casa della Vita. Ori e Storie intorno
all’antico cimitero ebraico di Bologna", curata e organizzata dal Museo
Ebraico di Bologna e dalla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio
per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e
Ferrara, in collaborazione con
Comunità Ebraica di Bologna.
La mostra, aperta dal 20 giugno 2019 al 6 gennaio 2020 consente di ripercorrere,
in modo globale e sistematico, la storia di una minoranza, dei suoi usi, della
sua cultura e delle sue interazioni con la società cristiana del tempo.
Una settantina di reperti riaffiorati dal sottosuolo danno testimonianza di un
luogo di cui le fonti archivistiche attestavano l’esistenza ma di cui si era
perduta ogni traccia, e sollevano interrogativi che ridestano ancora una volta
curiosità verso un’epoca tra le più interessanti ed enigmatiche della storia
culturale italiana.

L'area di scavo in Via Orfeo a Bologna
“Dalla condivisione al ghetto. Lo spazio degli Ebrei a Bologna dal XIV al XVI
secolo” è il film appositamente prodotto dal Museo Ebraico di Bologna per
narrare una storia, quella della Bologna ebraica, ancora inedita e di grande
rilievo.
In mostra anche documenti provenienti dall’Archivio Generale Arcivescovile e –
dal 15 settembre 2019, in occasione della Giornata Europea della Cultura Ebraica
– la riproduzione fotografica del Canone di Avicenna, fondamentale summa del
sapere medico di allora, di cui la Biblioteca Universitaria di Bologna conserva
un superbo manoscritto del XIV secolo ornato da splendide miniature a piena
pagina con scene che illustrano le principali pratiche mediche e terapeutiche.
Nel Ventennale del Museo Ebraico di Bologna si torna parlare della presenza
ebraica tra Quattro e Cinquecento in uno dei centri più importanti dell’ebraismo
italiano.
Durante il periodo della mostra, un percorso espositivo diffuso tra musei e
istituzioni culturali della città –Museo civico Medievale, Biblioteca
Universitaria, Museo Internazionale della Musica, Museo del Patrimonio
Industriale, Museo civico del Risorgimento-Certosa di Bologna– consentirà al
pubblico di conoscere luoghi, episodi e persone che hanno fatto la storia
ebraica di Bologna dipingendo un quadro complessivo di grande respiro e
insospettabile ricchezza.
A corredo dell'esposizione è stato pubblicato il volume "Il Cimitero ebraico medievale di Bologna:
un percorso tra memoria e valorizzazione" curato da Renata Curina e Valentina Di
Stefano, che sarà presentato Giovedì 11 luglio 2019, alle ore
17, nel Salone d'Onore di Palazzo Dall’Armi Marescalchi (sede SABAP-BO), via IV
Novembre n. 5 a Bologna.
Il volume, che esce grazie al contributo della Fondazione del Monte di Bologna e
Ravenna, è il tredicesimo della collana DEA, Documenti ed Evidenze di Archeologia,
della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. Il
volume
MEB
- Museo Ebraico di Bologna
via Valdonica 1/5
40126 Bologna (Italy)
Tel. +39 051.2911280 - Fax +39 051.235430 -
info@museoebraicobo.it -
http://www.museoebraicobo.it/it
La mostra è visitabile dal 20 giugno 2019 al 6 gennaio 2020 nei
seguenti orari: da domenica a giovedì ore 10 > 17.30, venerdì ore 10 > 15.30
(chiusa sabato e festività ebraiche)
entrata € 7.00 intero | € 5.00 ridotto
Lo scavo e i reperti
di Renata Curina e Valentina Di Stefano
La vasta area occupata dal cimitero ebraico medievale è compresa
nell’isolato delimitato dalle vie Orfeo, de’ Buttieri, Santo Stefano e
Borgolocchi. Le indagini archeologiche, avviate per la costruzione di un
condominio, hanno interessato solo una parte dell’area funeraria, della quale
non si conosce l’estensione completa. Lo scavo ha raggiunto una profondità di
circa 5 metri, permettendo di portare alla luce testimonianze archeologiche
dall’età preistorica all’età moderna.
Di estremo interesse è la fase compresa tra XIV e XVI secolo, momento in cui
l’area è destinata al cimitero: le circa 400 tombe indagate presentano
un’organizzazione molto sistematica, con una disposizione per file parallele
orientate nord-sud, soprattutto nel settore occidentale.
Per rispettare il precetto dell’individualità della sepoltura, le tombe sono
distanziate tra loro da una fascia di rispetto. I defunti, tranne alcuni casi
isolati, sono collocati in posizione supina, con il capo collocato a ovest, le
braccia distese lungo i fianchi o disposte sul petto. Le fosse sepolcrali
contenevano casse di legno chiuse con chiodi di ferro, al cui interno i defunti
erano deposti avvolti in sudari, secondo le tradizioni religiose ebraiche.
Sui corpi dei defunti sono stati rilevati i segni evidenti di una sistematica
attività di danneggiamento delle salme, che ha determinato la manomissione di
circa la metà delle sepolture. A causa dei danneggiamenti subiti, non si
conservano nella sede originale le lapidi e i segnacoli delle tombe, ma la loro
presenza è ricostruibile dalle strutture murarie conservate che dovevano esserne
le basi. L’attività di manomissione delle sepolture di via Orfeo sembra
rispondere ad una razionale volontà di depredare eventuali elementi di corredo e
di distruggere qualunque traccia della memoria delle tombe ebraiche.
Durante lo scavo archeologico del cimitero di via Orfeo sono stati recuperati
numerosi oggetti deposti insieme ai defunti, come elementi di ornamento, sia in
funzione personale sia simbolica. I materiali, che si inquadrano in un arco
cronologico compreso tra XV e XVI secolo, confermano la datazione del cimitero
ricavata dalle fonti storiche e archivistiche.
Tra i materiali rinvenuti si segnala una netta prevalenza di anelli, nella
maggior parte dei casi ottenuti per fusione in lega d’oro e sono del tipo con
castone, fedi nuziali e vere.
Nello scavo sono stati recuperati anche alcuni orecchini, a cerchio semplice o a
cerchio con tre globetti cavi, dei quali sono noti altri esemplari provenienti
da contesti funerari ebraici.
Di particolare interesse risultano i 31 vaghi di ambra, uno di calcedonio e uno
d’agata che, presentati ricomposti, facevano parte di una collana o di un
rosario.
Una così numerosa presenza di oggetti in materiali preziosi sembra delineare per
il cimitero di via Orfeo un quadro sociale piuttosto elevato.
L’attività di manomissione delle sepolture di via Orfeo sembra rispondere ad una
razionale volontà di depredare eventuali elementi di corredo e di distruggere
qualunque traccia della memoria delle tombe ebraiche.
Storia e Memoria
di Renata Curina e Valentina Di Stefano
Le fonti storiche e archivistiche permettono di indicare con
precisione il periodo di uso dell’area di via Orfeo come cimitero ebraico.
L’Archivio di Stato di Bologna conserva il riassunto dell’atto notarile, datato
8 agosto 1393, con cui Elia ebreo Di Orvieto acquista l’appezzamento di terra
ortiva e alberata, presso il Monastero di San Pietro Martire, dove verrà
impiantata l’area funeraria.
Dopo un lungo periodo di prosperità economica e di grande vivacità culturale,
nel corso del XVI secolo la componente ebraica della città subisce gli effetti
di un netto inasprimento delle politiche papali e delle restrizioni imposte agli
ebrei.
La Bolla Hebraeorum gens emanata nel 1569 da papa Pio impone la cacciata degli
ebrei dallo Stato Pontificio, con eccezione degli abitanti delle città di Roma,
Ancona e Avignone. Nello stesso anno, il 29 novembre, il Pontefice promulga un
Breve con il quale interviene direttamente sulla situazione bolognese, imponendo
il passaggio della proprietà del terreno del cimitero ebraico alle monache del
Monastero di San Pietro Martire.
Il documento pontificio autorizza a “disseppellire e far trasportare, dove loro
piaccia, i cadaveri, le ossa e gli avanzi dei morti; di demolire o trasmutare in
altra forma i sepolcri costruiti dagli ebrei, anche per persone viventi; di
togliere affatto, oppure raschiare e cancellare le iscrizioni ed altre memorie,
anche scolpite nel marmo”. Papa Pio V dispone la profanazione delle sepolture e
la distruzione del cimitero ebraico di via Orfeo, con l’obiettivo di cancellare
ogni traccia della presenza degli ebrei a Bologna.
Il ricordo della presenza del cimitero ebraico rimane nelle fonti d’archivio
nella dicitura “Orto degli Ebrei”, che si conserva fino al XVIII secolo
inoltrato nei Bilanci del Monastero di San Pietro Martire, in cui vengono
registrati regolarmente le cifre ricavate dall’affitto del terreno come orto.
1393 - 1569: 176 anni in cui sono racchiuse alcune delle pagine tanto
entusiasmanti culturalmente quanto politicamente drammatiche della storia di
Bologna tra Medio Evo e Rinascimento.
Cimiteri Ebraici in Emilia-Romagna
di Vincenza Maugeri
Tra i siti urbanistici legati alla storia e alla presenza delle comunità
ebraiche, il cimitero rappresenta un’entità estremamente indicativa, oltre che
la più diffusa.
L’insediamento di un nucleo ebraico in un territorio comportava la creazione di
specifiche strutture destinate agli usi propri della comunità, quali
principalmente sinagoghe e luoghi destinati alle sepolture distinti e separati
dai cimiteri cristiani.
Della presenza ebraica in Europa e in Italia, tra le numerose testimonianze di
carattere urbanistico, i cimiteri ebraici sono quelli che offrono i numerosi
spunti di riflessione e di ricerca.
Siano essi espressione di una comunità ancora esistente e attiva o, più spesso,
di una comunità ormai scomparsa, rappresentano a tutti gli effetti “monumenti”,
archivi e al tempo stesso musei a cielo aperto, dove storia, memoria, arte si
saldano strettamente e dove i cambiamenti succedutisi nel corso dei decenni sono
leggibili se attentamente e puntualmente studiati.
Le case della vita aprono a diversi ambiti di indagine sul tessuto sociale,
economico, religioso, demografico di una data comunità. E non ultimo sulla
ricerca di uno stile “giudaico”, soprattutto tra secondo Ottocento e primi
decenni del Novecento, poiché lo spazio cimiteriale ha costituito uno sbocco
importante per l’espressione della creatività artistica e architettonica e per
le scelte stilistico-figurative che lo hanno caratterizzato.
Nel territorio emiliano-romagnolo, sono 19 i cimiteri ebraici rimasti, in gran
parte risalenti al XVIII-XIX secolo, ma più antichi ancora nel caso di Ferrara,
Lugo e Finale Emilia, spesso rimasti come uniche testimonianze di un’antica e
rilevante presenza ebraica, della memoria culturale e spirituale di una
comunità, dunque luoghi di identità e fonte di studio per la ricostruzione dei
gruppi familiari.
Attività, professioni, medici e intellettuali nella Bologna
Ebraica tra XV e XVI secolo
di Caterina Quareni
Per tutto il XV fino alla metà del XVI secolo, gli ebrei che si
insediano a Bologna si dedicano al commercio, in particolare di panni e stoffe
di seta, al prestito di denaro, alla tipografia, oltre che a molti altri umili
mestieri (di sarto, calzolaio, ambulante).
Alcuni mestieri sono collegati alla vita stessa e all'organizzazione della
comunità; non mancano, tra gli altri, gli addetti (shochetim) alla
macellazione rituale della carne, attività concessa e regolata da specifiche
clausole contenute nelle “condotte”, i contratti stipulati con il governo
cittadino, che, tra l'altro, concedono anche di vendere ai cristiani le parti
vietate nell'alimentazione ebraica (kasheruth) come i posteriori e le
interiora degli animali. È documentata inoltre nella comunità bolognese la
presenza di un ebreo cocchiere, di un oste in contrada Caldarese e di un musico
e cantante, tale Simone di Emanuele Del Ben.
Tra la fine del Trecento fino al 1569, data dell'espulsione degli ebrei da
Bologna, la città è uno dei centri più vivi della cultura ebraica della nostra
penisola. Ne sono testimonianza il congresso dei rappresentanti delle comunità
ebraiche dell'Italia centro-settentrionale, tenutosi a Bologna nel 1416 e
l'istituzione nel 1464 di una cattedra di ebraico presso lo Studio bolognese.
Nell'incrociarsi dei flussi migratori determinati dalle espulsioni da paesi
vicini, la tradizione ebraica locale si arricchisce degli apporti della cultura
sefardita e di quella ashkenazita. Il risultato è lo sviluppo di una fiorente
attività di copiatura e di decorazione di manoscritti ebraici di carattere
religioso, letterario e scientifico redatti secondo le tre principali tradizioni
scrittorie dell'Occidente.
Tra il 1477 e il 1488 fiorisce la tipografia ebraica bolognese di Yosef ben
Avrahàm Caravita, dalla quale escono nel 1477 la stampa dell'editio princeps
dei Salmi con il commento di David Qimchi e nel 1482 quella commentata del
Pentateuco (Torah). A quest'ultima opera lavora, Avraham ben Hayyim dei
Tintori da Pesaro, uno dei più abili tipografi dell'epoca, noto per aver risolto
i problemi tecnici legati alla vocalizzazione delle lettere ebraiche.
Non mancano le traduzioni, dall’ebraico al latino e dalle lingue classiche
all’ebraico: il rabbino Azariah de' Rossi, uno dei “Soci” legati a Ovadyah
Sforno, traduce in ebraico, la Lettera di Aristea a Filocrate, testo in greco
ellenistico del II secolo a.e.v.
Parecchi sono poi gli ebrei che esercitano la medicina, raramente con lauree
ottenute presso le università di Padova, Bologna, Ferrara, ecc. ma, assai più
spesso, muniti di semplice licentia practicandi. A Bologna, nel 1410, abbiamo
notizia del magister Elia, medico apprezzato e benvoluto anche da Enrico IV
d’Inghilterra e dal marchese Lionello d’Este, di un Angelo di Isacco a cui viene
conferita la laurea, di Mosè di magister Abramo Finzi da Reggio, ebreo da
Longiano, che ottiene il titolo accademico per diretta concessione del papa nel
1543. Fino al 1528 è attestata anche la presenza di Jacob Mantino, famoso per la
traduzione dall'ebraico al latino delle opere di Averroè e Avicenna.
BOLOGNA EBRAICA
In parallelo alla mostra la Casa della Vita. Ori e storie intorno
all’antico cimitero ebraico di Bologna, un percorso espositivo, ideato in
collaborazione con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di
Bologna, diffuso in musei e istituzioni culturali cittadine e altri eventi
collaterali offrono l’occasione di conoscere luoghi, episodi, persone che hanno
fatto la storia ebraica di Bologna, componendo un quadro di grande respiro,
originale e di ricchezza insospettabile.
• Museo Civico Medievale | Via Manzoni, 4
conserva quattro lapidi cinquecentesche, le uniche superstiti provenienti
dal cimitero ebraico di via Orfeo, dedicate a: Avrahàm Yaghèl da Fano (1508);
Shabbetay Elchanàn di Rieti (1546); Menahèm Ventura (1555); Yoav da Rieti (1555)
orari apertura: tutti i giorni 10-18 | chiuso lunedì non festivi
€ 6,00 intero | € 3,00 ridotto |gratuito Card Musei Metropolitani Bologna
• Museo Internazionale e Biblioteca della Musica |Strada Maggiore, 34
dal 20 giugno 2019 un approfondimento espositivo su Salomone Rossi e sulla
sua musica
15 settembre 2019 - Giornata Europea della Cultura Ebraica: visita guidata
gratuita alla sezione dedicata a Salomone Rossi
17 settembre 2019 ore 21.00, Sarajevo, Chico Yerushalaim, concerto di Sasha
Karlic & Yefira
Info e prenotazioni: tel. 051 2757727
• Museo Patrimonio Industriale |Via della Beverara 123
dal 20 giugno 2019 un approfondimento sull’industria della seta ed ebrei a
Bologna
info sugli orari www.museibologna.itr/patrimonioindustriale
15 settembre 2019 - Giornata Europea della Cultura Ebraica: visita guidata
gratuita
Info e prenotazioni: tel. 051 6356611 – museopat@comune.bologna.it
• Biblioteca Universitaria di Bologna |Via Zamboni, 35
15 settembre 2019 - Giornata Europea della Cultura Ebraica esposizione di
preziosi manoscritti ebraici della raccolta della Biblioteca
apertura dalle 10 alle 18 e visita guidata
info e prenotazioni bub.info@unibo.it
• Museo Civico del Risorgimento – Certosa di Bologna
Cimitero Monumentale della Certosa via della Certosa 18
domenica 22 settembre | ore 10.30
“La casa dei viventi”: il cimitero ebraico di Bologna
visita gratuita guidata con Cesare Barbieri
Info e prenotazioni: 0516569003
ALTRI EVENTI
17 settembre 2019 ore 18.00 |Museo Ebraico di Bologna
Visita guidata alla mostra La casa della vita
Ori e Storie intorno all’antico cimitero ebraico di Bologna
Info e prenotazioni: info@museoebraicobo.it – tel. 051 6569003
19 settembre 2019 ore 17.00 | Museo Ebraico di Bologna
Giovanni di Niccolò Bellini, un miniatore veneziano per la comunità ebraica
di Bologna (sec.XV)
conferenza di Massimo Medica, Direttore Musei d’Arte Antica
Visite alla mostra e alla Bologna ebraica anche nel programma di
Cool Tour Street 17-30 giugno 2019:
vedi programma completo su www.museoebraicobo.it
vai alla pagina dedicata al Cimitero Ebraico Medievale di Bologna
Comunità spesso di piccole dimensioni ma con un ruolo fondamentale nella
storia delle città e delle nazioni, persone in gran parte sconosciute, spesso
discriminate, ma che proprio per questo vivono il presente e guardano al futuro.
La storia della Comunità Ebraica di Bologna si è arricchita in anni recenti di
un ulteriore, prezioso tassello, quel Cimitero Medievale narrato dalle carte ma
di cui si era persa traccia. Un nuovo spazio della memoria che si è aggiunto al
nuovo memoriale della Shoah di Bologna, sorto nella nuova piazza
tra via Carracci e il ponte di via Matteotti, inaugurato il 27 gennaio 2016.
Inaugurazione della mostra giovedì 20 giugno 2019 | ore 18.30
Museo Ebraico di Bologna | via Valdonica 1/5
sono presenti
Guido Ottolenghi, Presidente Fondazione Museo Ebraico di Bologna
Cristina Ambrosini, Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio
BO-MO-RE-FE
Daniele De Paz, Presidente Comunità Ebraica di Bologna