In mostra al Museo Archeologico Sarsinate gli
splendidi disegni ricostruttivi della necropoli romana di Pian di Bezzo
realizzati da Traiano Finamore durante gli scavi condotti tra gli anni Venti e
Trenta sotto la direzione di Salvatore Aurigemma
L'esposizione è corredata da pannelli illustrativi relativi allo scavo, al
recente restauro e alla valorizzazione del monumento funerario di Obulacco,
risalente al I sec. a.C.
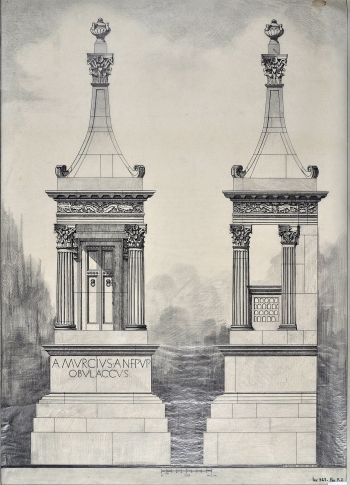 IL
MONUMENTO DI OBULACCO
IL
MONUMENTO DI OBULACCO
DALLA SCOPERTA AD OGGI
Sarsina (FC),
Museo Archeologico Nazionale
Via Cesio Sabino 39
info (+39) 0547 94641 -
sar-ero.museoarchsarsina@beniculturali.it
Dal 7 dicembre 2014 al 31 agosto 2015
negli orari di apertura del museo
ingresso € 3,00
Il silenzio dei sepolcri è meno muto guardando i disegni ricostruttivi
realizzati negli anni Trenta da Traiano Finamore. I preziosi dettagli, le
immagini a volo d'uccello sono un 3D ante litteram in due dimensioni che
sprigiona una potenza espressiva in anticipo di decenni sulle ricostruzioni virtuali dei nostri tempi.
Correva l'anno 1927 quando iniziarono le prime campagne di scavo a fondovalle di
Sarsina, nell'area della necropoli di Pian di Bezzo.
Le indagini continuarono fino al 1933 sotto la direzione di Salvatore Aurigemma
che si avvaleva dell’assistenza di Francesco Proni e della preziosa opera
grafica di Traiano Finamore, detto Nino, nel suo ruolo di disegnatore dell’allora Ministero della
Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti. Traiano Finamore
era nato a Lanciano (CH) il 14 gennaio 1899. A lui si devono
tutti i rilievi grafici dei monumenti, eseguiti prima in corso di scavo, poi
come rilievi, le sezioni e le ricostruzioni assonometriche in fase di studio
preliminare, finalizzate proprio della ricomposizione dei monumenti.
Il recente restauro del Mausoleo di
Obulacco ha fornito l’occasione per allestire, nella piccola aula al II
piano, una mostra documentaria che illustra, con pannelli tematici, le
principali fasi degli interventi attuati, dallo scavo del 1929 al restauro di
oggi. Il restauro, resosi necessario a causa della collocazione in
ambiente esterno e allo sciame sismico registrato a Sarsina nell'anno 2011, è
stato diretto dalla Soprintendenza Archeologia dell'Emilia-Romagna e
finanziato dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.
La
documentazione grafica e fotografica, conservata negli archivi della
Soprintendenza Archeologica dell’Emilia-Romagna ha consentito di proporre al
pubblico alcune tappe della “strada” fatta dal monumento che oggi torna a
“risplendere” nello stesso luogo dove fu rimontato fin dal lontano 1938 (il
Parco delle Rimembranze) come monumento commemorativo dedicato (oggi come
allora) ai Caduti di tutte le Guerre.
Il Monumento di Obulacco dalla scoperta ad oggi. Lo scavo e la ricostruzione
La mostra illustra le tappe percorse dal monumento di Obulacco dal momento
del rinvenimento nel 1929 a oggi.
Come in occasione dei festeggiamenti per il restauro del cenotafio di Obulacco, possiamo parlare di “Obulacco e la sua
strada", strada nell’alternanza di significato reale e simbolico, a partire dal
luogo dove era collocato come imponente monumento funerario auto celebrativo
quando si ergeva sulla strada della necropoli romana di Pian di Bezzo.
Strada che hanno percorso i pezzi smembrati del monumento per essere trasportati
da Pian di Bezzo al Museo; strada dai primi interventi di restauro fino
all’intera ricomposizione sulla Strada Nazionale, e infine strada che ancora
occupa (e che in parte ricalca il tracciato di quella antica), rivestendo un
alto significato per la città.
Di fondamentale importanza sono stati gli anni della scoperta e del successivo
intervento di restauro e ricostruzione, e i lavori di rilevamento e restituzione
grafica e assonometrica eseguiti dal prof. Traiano Finamore, disegnatore della
Soprintendenza Archeologica di Bologna. In mostra, oltre a un pannello che ne
ricorda la figura, le doti artistiche e la grande professionalità, sono esposte
alcune riproduzioni dei disegni da lui eseguiti sui monumenti della necropoli di
Pian di Bezzo.
Sappiamo infatti che il monumento di Obulacco non era il solo sull'antica strada: era
affiancato dal mausoleo ”gemello” (rimasto incompiuto) del figlio Oculatio
mentre di fronte si ergeva l’imponente mausoleo di Rufo e poco oltre, di lato,
quello a dado di Verginio Peto.
I tre monumenti sono esposti in Museo, ma alcuni disegni di Finamore esposti a
fianco di quelli di Obulacco, consentono di rivederli insieme.

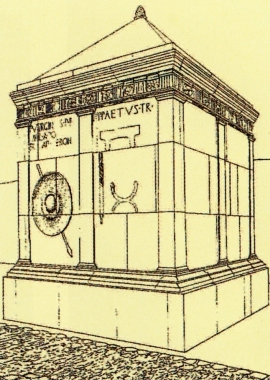
Disegni ricostruttivi di Traiano Finamore. A sin. Veduta generale della
necropoli di Pian di Bezzo; a des. il sepolcro a dado di Verginius Paetus, con
fregio dorico e insegne civili e militari
Il protagonista indubbio della mostra è però il monumento di Obulacco ed è ad
esso che è rivolta la restante documentazione: le prime stampe di vecchi
negativi su lastre in vetro mostrano lo stato di crollo in cui versava il
manufatto Obulacco all’atto del
rinvenimento, crollo causato dal movimento franoso che occultò la necropoli agli inizi
del III sec. d.C. Altre foto mostrano le prime prove di "rimontaggio" fatte
quando i resti erano ancora in situ e poi all’interno del Museo, fino alla compiuta ricostruzione e inaugurazione nel 1938-39
nel Parco delle Rimembranze, dove si trova
tuttora.
Le foto fanno da "spalla" alle pagine dei diari
dei primi lavori eseguiti a partire dagli anni 30 dove è possibile
ammirare la grande perizia tecnica e grafica di
schizzi e sezioni. Le pagine ingiallite e l’inchiostro di china ne segnano il
tempo, suscitando il fascino della rievocazione.
Pur nella specificità del tema trattato, la mostra può esser meglio compresa
effettuando preliminarmente la visita al Museo dove, nelle cinque sale al pianterreno,
sono esposti gli eccezionali rinvenimenti della necropoli di Pian di Bezzo, a
partire dalle prime due sale che espongono lapidi, cippi e stele funerarie,
frutto delle prime raccolte occasionali di almeno tre secoli addietro, fino ad
arrivare ai grandi monumenti di Peto e Rufo, restituiti interi dopo gli ultimi
interventi di ampliamento e riallestimento del Museo conclusosi nel 1990. Il
susseguirsi dei monumenti sepolcrali consente di ripercorrere idealmente
sempre la stessa strada, popolata da altri personaggi e scelta dagli antichi Sarsinati, a partire dalla seconda metà del I sec a.C. fino alla fine del II
secolo, come luogo per la loro ultima dimora.

Sarsina, Museo Archeologico Nazionale. Lapidi, cippi e stele funerarie dalla
necropoli di Pian di Bezzo
Dopo la visita al pianterreno -che riserva altri sorprendenti reperti quali
il grande mosaico del cosidetto Trionfo di Dioniso, il ciclo statuario delle
Divinità Orientali e interessanti documenti epigrafici restituiti
dall’antico centro cittadino- salendo al primo piano e dopo una sosta
nella sala A recentemente allestita per illustrare le fasi preromane di Sarsina e del territorio circostante, si può riprendere il percorso legato alla
necropoli visitando la sala B appena riallestita.
Le quattro vetrine a muro
utilizzate fin dagli anni '70 per esporre i materiali rinvenuti durante
le prime campagne di scavo degli anni Trenta, sono state” movimentate”
raggruppando i singoli corredi sepolcrali.
Ai vecchi materiali sono stati aggiunti quelli rinvenuti nelle ultime
tre campagne di scavo degli anni Ottanta, selezionando tra le 25 tombe esplorate
i 14 corredi più significativi.
Nuovo è anche il cospicuo apparato didascalico, parte del quale situato
all'interno delle vetrine e parte sui leggii che le affiancano. Nell’insieme si è cercato di illustrare, seguendo il percorso delle
esplorazioni sistematiche lungo l’asse stradale della necropoli (le prime
risalenti agli anni '30, le ultime degli anni '80), alcuni corredi nel loro excursus
cronologico e nel loro diversificarsi tra uomini, donne e bambini, oltre agli
aspetti legati ai vari riti di sepoltura e alla ritualità funebre
richiamati proprio dai diversi oggetti utilizzati durante il funerale e la
commemorazione.
Alcune urne cinerarie, una coppetta in vetro policroma, parti di un frustino e
un’applique in bronzo raffigurante il mito di Europa sul Toro sono certamente oggetti eccezionali, ma
che vivono veramente solo all’interno del proprio
contesto, insieme agli altri oggetti del corredo cui appartenevano, da cui
risalire ai rispettivi defunti o defunte e ai loro mestieri.

Applique in bronzo raffigurante il mito di Europa sul toro
Si è lasciata nella sala anche la ricostruzione di una tomba alla cappuccina appartenuta a una donna
(senza
nome in quanto senza lapide), perché la sua
presenza è importante sia per far capire ai visitatori com’era fatto questo tipo
di sepoltura, sia per evidenziare i materiali di un corredo prettamente femminile.
Sulla parete alle sue spalle campeggia ora l’immagine della strada
sepolcrale, fedele riproduzione di una xilografia di Traiano Finamore che,
col suo tratto artistico, ha saputo ricreare un’atmosfera magica ridando “vita”
alla necropoli, nonostante fosse la “città dei morti”.
I suoi disegni sono tuttora una finestra temporale aperta su una città
dei morti che, come tutte le necropoli romane, raccontava il potere dei vivi.
La necropoli di Pian di Bezzo
La legge romana vietava ogni sorta di sepoltura all'interno delle mura delle
città. Questo divieto, disposto a partire dall’età repubblicana, determinò la
pianificazione delle aree cimiteriali all’esterno al perimetro urbano,
privilegiando i margini delle strade di accesso alla città, ai cui lati si
distribuivano le sepolture, soprattutto quelle monumentali.
I sepolcreti trovati a Sarsina erano situati a nord e a sud dell’asse stradale
che usciva dalla città. La necropoli ubicata a nord ha restituito solo semplici
sepolture a fossa mentre la necropoli di Pian di Bezzo, ubicata a sud lungo i
lati della strada di fondovalle, è apparsa subito la preferita da chi voleva
manifestare con forza il proprio status.
La necropoli di Pian di Bezzo restò in uso dal I sec. a.C. sino alla fine del II
secolo d.C., quando venne abbandonata a causa di una frana che ne provocò
l'interramento. A tutt'oggi non ancora delimitata nei suoi confini, è stata
esplorata per un tratto di circa 150 metri (scavi 1927-33 e 1981-84) costituito
da un settore monumentale più antico e da uno più recente, con semplici
sepolture terragne (per un totale di 116 tombe di cui 92 compiutamente
indagate).
Si tratta di una necropoli estremamente variegata: delle 92 tombe scavate, ben
25 presentavano forme varie di monumentalizzazione, dal sepolcro a camera ipogea
al monumento a tamburo cilindrico, dai due monumenti a dado ai cinque mausolei a
edicola. Le altre sepolture erano indicate da are, cippi o stele, queste ultime
spesso a edicola o a porta.
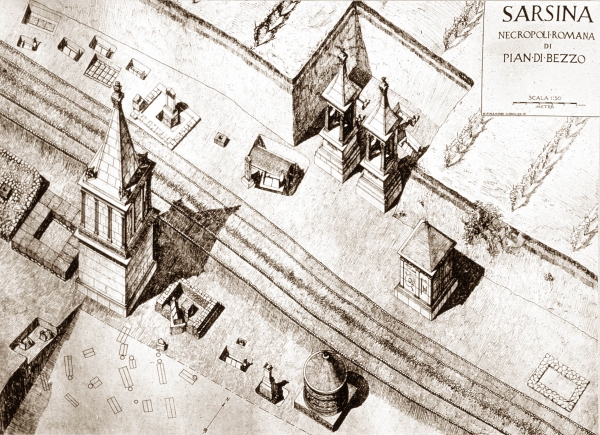
La necropoli di Pian di Bezzo nel disegno di Traiano Finamore
Gli eccezionali monumenti funerari rinvenuti nella necropoli di Pian di Bezzo
sono in parte visibili nel museo, dove spicca per imponenza il Mausoleo di Rufus
o il monumento a dado di Virginio Peto.
Costante in tutti i tipi è l’iscrizione che conteneva sempre i dati anagrafici
del defunto, accompagnati spesso dal nome di coloro che avevano predisposto la
sepoltura. Le iscrizioni sepolcrali sarsinati ci consentono di conoscere i suoi
antichi abitanti, siano semplici formulari espressi con sigle e abbreviazioni
oppure manifestazioni di tipo affettivo, indichino la professione o le cariche
civili o militari rivestite oppure attestino norme giuridiche di diritto
privato.
La necropoli di Pian di Bezzo documenta infine raggruppamenti di tombe per
nuclei familiari o professionali, come testimonia il nucleo dei Murcii (cui
appartenevano sia Obulacco che Oculatio) o quello dei defunti appartenenti al
collegium dei muliones riconosciuto da una stele che ricorda il lotto sepolcrale
(locus) destinato ai mulattieri sarsinati.
Traiano Finamore (1899-1970)
Studioso ed artista di raffinata sensibilità e cultura, ben maggiore di quanto
non lasciasse trasparire la sua indole modesta e schiva, Traiano Finamore, detto
Nino, era nato a Lanciano (Chieti) il 24 gennaio 1899.
Conseguita la licenza liceale nel 1917, durante la Grande Guerra partì
volontario per il fronte. Ufficiale di complemento del 139° Reggimento di
Fanteria, nell’ottobre 1918, combattendo sul monte Asolone, fu ferito gravemente
ad un piede; come mutilato ottenne il conferimento di “croce al merito di
guerra”.
Interrotti gli studi universitari in Legge, nei primi anni Venti fu indirizzato
dai celebri artisti Francesco Paolo Michetti e Giulio Aristide Sartorio verso le
discipline artistiche: prospettiva, anatomia plastica e pittorica, incisione,
decorazione pittorica e in modo particolare la xilografia acquaforte. In
quest’ultimo settore raggiunse risultati considerevoli, tant’è che alcune sue
tavole furono inserite nella raccolta “La moderna
xilografia italiana” di Cesare Ratta, che raccolse in 6 volumi 150 tavole
dei maggiori artisti italiani (Bologna, 1927-1929). Questa sua peculiare
preparazione artistica gli consentì di iniziare nel 1927 l’attività di
“disegnatore straordinario” con contratti a termine per l’allora Ministero
dell’Educazione Nazionale - Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti.
Dopo aver trascorso un primo periodo a Roma, presso il R. Museo Nazionale di
Villa Giulia, curando in particolare il disegno di vasi, nel 1928 prese servizio
alla “Soprintendenza alle Antichità dell’Emilia-Romagna in Bologna”. Con lo
stesso incarico giunse a Sarsina per prestare la sua preziosa opera durante gli
scavi nella necropoli di Pian di Bezzo, allora diretti da Salvatore Aurigemma.
Di fondamentale importanza sono i rilievi planimetrici, i disegni assonometrici
e quelli ricostruttivi dei monumenti che tuttora possiamo ancora ammirare.
Divenuto nel giugno del 1937 disegnatore di ruolo, fu chiamato ad operare,
sempre per conto della Soprintendenza, in altre realtà della Regione, come a
Rimini nel 1937, in occasione delle manifestazioni indette per il bimillenario
di Augusto e a Ferrara, per disegnare i vasi attici rinvenuti nella necropoli di
Spina.
Nel 1939 Luigi Morricone, allora direttore dell’Ufficio Archeologico FERT di
Rodi, richiese la sua presenza nell’isola di Coo, per iniziare lo studio dei
monumenti venuti alla luce. Così in quello stesso anno, e successivamente nel
1942, Finamore, lavorando a fianco degli studiosi italiani, condusse due
campagne di rilevamento, base per le restituzioni grafiche che dovevano
costituire il supporto illustrativo degli studi sui monumenti. Anche qui, come a
Sarsina, la sua prestazione fu di rilevante importanza per la condotta degli
scavi e lo studio dei reperti.
L’ultimo periodo della sua attività e della sua vita fu però dedicato a Sarsina,
dove aveva espressamente richiesto di essere trasferito e dove fissò la sua
dimora, a fianco dell’amata consorte prof.ssa Ezia Rossi.
Collocato a riposo nel 1950, subito dopo, nel gennaio 1951, fu nominato
Conservatore Onorario del Museo Nazionale, dove continuò a profondere il suo
impegno, determinante per l’acquisto dello stabile da parte dello Stato (1957) e
per ottenere i finanziamenti per tutti i lavori di ampliamento. Il suo lodevole
servizio e la sua competenza gli valsero il riconoscimento, già nel 1958, di
medaglia di bronzo per meriti acquisiti nel campo della cultura.
Mentre riuscì a seguire la costruzione della nuova sala al pianterreno dedicata
alle Divinità Orientali (inaugurata nel 1967), non ebbe modo di vedere compiuto
l’ampliamento del museo al secondo piano (aperto al pubblico nel 1976), poiché
si spense il 7 maggio 1970.
Profondamente stimato ed amato oltre che compianto da tutti i Soprintendenti con
cui aveva collaborato, è rimasto nel cuore anche di tutti i cittadini sarsinati,
che da Lui hanno imparato a prestare attenzione alle “antichità” della loro
città.
Il Monumento di Obulacco dalla scoperta ad oggi
Museo Archeologico Nazionale di Sarsina, 7 dicembre 2014 - 31 agosto 2015
Mostra a cura di Monica Miari, Maria Teresa Pellicioni, Antonella Pomicetti,
Mauro Ricci
Testi di Monica Miari, Maria Teresa Pellicioni, Piergiorgio Pellicioni,
Antonella Pomicetti, Mauro Ricci
Foto Roberto Macrì (SBAER), CLESSIDRA s.n.c.
Apparato grafico: Rossana Gabusi (SBAER)
Grafica manifesto: Paolo Baronio
Si ringrazia per la collaborazione: il personale del Museo di Sarsina, il Comune
di Sarsina, Paolo Baronio, Tamara Bosi, Cristina Leoni
Allestimento Sala B a cura di Cristina Leoni (Phoenix Archeologia
s.r.l., Bologna)
Apparato grafico: Paolo Baronio
Testi: Paolo Baronio, Teresa Pellicioni (SBAER)
Coordinamento scientifico: Monica Miari (SBAER)
Restauro applique in bronzo: Valentina Guerzoni (SBAER)
Restauro monumento Obulacco finanziato dal Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali e del Turismo
Progettisti: Mattia Bonassisa, Monica Miari, Antonella Pomicetti, Mauro Ricci (SBAER)
Direttore dei lavori: Antonella Pomicetti (SBAER)
Coordinatore della sicurezza: Walter Zoffoli
Impresa esecutrice: CLESSIDRA s.n.c. di Iemmi Fabio e C. di Reggio Emilia (Lisa Cilloni
e Prisca Sala, restauratrici)
Indagini diagnostiche: Istituto di Diagnostica e Sperimentazione per il Restauro
dei Beni Culturali di Ferrara
Riproduzione balaustra: DM MARMI di Riccione
Si ringrazia il Comune di Sarsina per il ripristino della recinzione e del verde,
e il restauratore Enrico Bertazzoli (SBA Piemonte)
 La visita del museo consente una lettura completa della storia di Sarsina,
dalla sua fondazione al III sec. d.C. Tra i reperti esposti si segnalano i
numerosi monumenti sepolcrali fra cui spicca, per imponenza e completezza, il
mausoleo a edicola cuspidale di Rufo (nella foto), risalente alla fine dei I sec.a.C., il mosaico policromo del “Il Trionfo di Dioniso”, gruppi scultorei di
divinità orientali, tra cui la statua del giovinetto Attis, e la ricostruzione
di un triclinium (sala da pranzo) con il pavimento originale a mosaico,
suppellettili di bronzo, vetro e ceramica.
La visita del museo consente una lettura completa della storia di Sarsina,
dalla sua fondazione al III sec. d.C. Tra i reperti esposti si segnalano i
numerosi monumenti sepolcrali fra cui spicca, per imponenza e completezza, il
mausoleo a edicola cuspidale di Rufo (nella foto), risalente alla fine dei I sec.a.C., il mosaico policromo del “Il Trionfo di Dioniso”, gruppi scultorei di
divinità orientali, tra cui la statua del giovinetto Attis, e la ricostruzione
di un triclinium (sala da pranzo) con il pavimento originale a mosaico,
suppellettili di bronzo, vetro e ceramica.
Orari museo
Orario invernale, dal 16 settembre al 14 giugno:
mercoledì, venerdì, sabato e domenica dalle 8.30 alle 13.30
martedì e giovedì 8.30-13.30 e 15-18
Orario estivo, dal 15 giugno al 15 settembre:
mercoledì, giovedì, sabato e domenica dalle 13.30 alle 18.30
martedì e venerdì 8.30-13.30
La biglietteria chiude mezz'ora prima