Ancora pochi per visitare la mostra che, dopo il grande successo dei primi mesi, era stata prorogata fino al 29 dicembre 2013
Attraverso i materiali provenienti da scavi recenti in città e nel suo circondario, il visitatore ripercorre il processo della formazione di Parma, a partire dai villaggi sparsi di età preromana che documentano i forti legami con il mondo etrusco e altri ambiti culturali circostanti, fino alla fondazione della colonia romana, definitivamente collocata là dove la città si svilupperà nei secoli successivi
 STORIE DELLA PRIMA PARMA
STORIE DELLA PRIMA PARMA
Etruschi, Galli, Romani: le origini della città alla luce delle nuove
scoperte archeologiche
Mostra archeologica Promossa da Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Generale per le Antichità e Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia Romagna, con il sostegno fondamentale di Fondazione Cariparma e il contributo del Comune di Parma. Da un progetto di «L’Erma» di Bretschneider
Museo Archeologico Nazionale di Parma - Palazzo della Pilotta
da sabato 12 gennaio a domenica 29 dicembre 2013
ingresso € 4,00 (ridotto € 2,00)
orari dal 3 al 30 giugno 2013: dal
martedì al venerdì dalle 9 alle 15 - sabato dalle 13 alle 19 - domenica
chiuso
orari dal 1 luglio al 30 settembre 2013:
dal martedì al venerdì dalle 9 alle 15 - sabato e domenica dalle 13 alle
19
Ferragosto aperta dalle 13 alle 19
orari dal 1 ottobre al 29 dicembre 2013:
dal martedì al venerdì dalle 9 alle 16.30 - sabato e domenica dalle 13
alle 19
(la biglietteria chiude mezzora prima)
Lunedì chiuso
info 0521 233718
Comitato scientifico:
Daniela Locatelli (Soprintendenza per i Beni Archeologici
dell’Emilia-Romagna)
Luigi Malnati (Direttore Generale per le Antichità)
Daniele F. Maras (Sapienza Università di Roma)
per scaricare la cartella stampa con immagini e
didascalie vai a
http://www.studiobegnini.it/index.php?section=eventi
Le fonti antiche raccontano che Parma, fondata come colonia romana nel 183
a.C., sorgeva su un territorio appartenuto prima agli Etruschi e poi ai Galli.
Sorta su un sito che all’attrattiva della disponibilità d’acqua e di terreno
abitabile aggiungeva la posizione lungo antichissime vie commerciali che
attraversavano la regione emiliana, Parma è pertanto una città nata più volte:
per questo motivo parliamo di ‘storie’, alludendo a momenti di sviluppo della
città che nel tempo hanno avuto caratterizzazioni diverse, determinando vere e
proprie soluzioni di continuità e nuovi ‘inizi’ della sua vicenda storica.
Le scoperte archeologiche dell’ultimo decennio, rimaste finora inedite, hanno
dunque riportato alla ribalta il ruolo del centro in epoca preromana nell’ambito
della regione emiliana occidentale, da sempre ‘terra di confine’ posta tra
l’Etruria propria e e le culture dell’Italia settentrionale (Veneti, Liguri,
cultura di Golasecca), nonché punto di passaggio obbligato per le comunicazioni
con i Celti d’Oltralpe.
Si tratta di una serie di insediamenti di tipo stabile e di sepolture che si
collocano intorno al centro urbano attuale e che testimoniano la continuità di
occupazione a partire almeno dal VII secolo a.C. avanzato. Caratterizzati dalla
presenza di materiali che denotano profondi legami con il mondo etrusco, questi
ritrovamenti mostrano al tempo stesso connotazioni riconducibili a una ‘cultura
mista’ determinata proprio dalla posizione della città e dal suo contatto con le
diverse culture circostanti, e consentono pertanto di chiarirne meglio il ruolo
storico anche nel più vasto ambito regionale.
Una stessa fortunata stagione di scavi e scoperte ha messo in luce i documenti
archeologici della prima occupazione di Parma in epoca romana, dopo la
‘parentesi’ gallica durata per oltre due secoli e di cui soltanto ora sono state
scoperte le prime testimonianze materiali.
È così risultato che, dopo la parentesi del V e del IV secolo a.C., le cui
scarse testimonianze sembrano attestare la riduzione o la scomparsa dei centri
abitati precedenti in corrispondenza con la prima presenza celtica nella pianura
Padana, nel corso del III secolo il popolamento di Parma ha conosciuto un
rinnovamento, in forme strutturate, con una concentrazione di tracce di abitato
nel sito della città attuale, che preludono all’installazione della colonia nel
183 a.C.
È perciò nel contesto di un centro già formato, il quale in età gallica
rivitalizzava il popolamento etrusco di età arcaica, che si installarono i
coloni Romani. Di questa colonia gli scavi degli ultimi decenni hanno rivelato
le testimonianze più antiche, sia dal punto di vista della vita civile che delle
forme di culto, dove meglio si esprime il confronto tra la cultura latina ed
italica con il mondo celtico e ligure.
Grazie a un esemplare incontro tra i dati archeologici e le fonti letterarie
(che in futuro avrà eco anche nei libri di scuola), viene così pienamente
confermato il resoconto dello storico latino Tito Livio, che ricorda come “a
Modena e a Parma furono fondate colonie di cittadini Romani, nel territorio che
poco prima era stato dei (Galli) Boi, e prima ancora degli Etruschi”.
Obiettivo primario della mostra, che coinvolge istituzioni pubbliche e
private, sia locali che nazionali, unite nel comune intento di promuovere e
diffondere la conoscenza dell’archeologia in ambito locale ed internazionale, è
la presentazione delle nuove scoperte di scavo avvenute in anni recenti nel
territorio di Parma, scoperte che contribuiscono a ridisegnare il quadro storico
finora noto per le fasi più antiche della città.
Per valorizzare nel senso più completo del termine tali ritrovamenti, si è
scelto da un lato un consistente aggiornamento dei dati noti accompagnato da
approfondimenti storico-critici attraverso una pubblicazione scientifica
destinata agli specialisti, dall’altro una ‘restituzione’ degli stessi dati alla
cittadinanza mediante un’esposizione temporanea rivolta al grande pubblico. Ciò
nella convinzione che portare fuori dal ristretto ambito accademico conoscenze –
che entrino a far parte del patrimonio di tutti e contribuiscano
all’acquisizione di una maggiore identità culturale – possa dare un maggiore
senso all’attività di tutela condotta quotidianamente dalla Soprintendenza, agli
oneri economici sostenuti dai tanti imprenditori che si trovano confrontarsi con
il problema dei rinvenimenti archeologici, ai piccoli disagi inflitti alla
cittadinanza con l’esecuzione degli scavi.
Le origini di Parma
Un famoso passo, Tito Livio racconta che nel 183 a.C. i
Romani fondarono le colonie di Parma e di Modena in un territorio che in
precedenza apparteneva ai Galli Boi e prima ancora agli Etruschi.
Lo storico ricorda però che Modena era già nota come città qualche anno prima (durante le campagne militari contro Annibale),
il che ci dice che la
colonia non fu fondata in un territorio vuoto e spopolato.
Ma che possiamo dire di Parma? Fino a pochi anni fa le informazioni
sulle sue origini erano molto scarse ma alcune scoperte archeologiche
dell’ultimo decennio non solo hanno dimostrato come ci fosse una città già prima
della fondazione della colonia, ma hanno portato prepotentemente alla ribalta il
ruolo del centro in epoca arcaica, tra il VI e il V secolo a.C., quando la
pianura Padana era saldamente sotto il controllo degli Etruschi.
In particolare, la regione emiliana occidentale è stata da sempre un importante
crocevia di culture, posto tra l’Etruria vera e propria e la pianura Padana, punto di
passaggio obbligato per le comunicazioni con l’Italia nord-occidentale e con
l’Europa centrale.
Nonostante l’enorme rilievo per gli studi sull’Italia arcaica, le sorprendenti
novità scaturite dalle recenti indagini della Soprintendenza sono rimaste fino
ad ora praticamente inedite e comunque sconosciute al grande pubblico.
La mostra
Per questo motivo, in contemporanea con l'uscita del volume scientifico che
presenterà al più alto livello i risultati della ricerca archeologica, il Museo Archeologico
Nazionale di Parma ospita la grande mostra dal titolo “Storie della prima
Parma. Etruschi, Galli, Romani: le origini della città alla luce delle nuove
scoperte archeologiche”, che aprirà i battenti dal 12 gennaio al 2 giugno 2013
(con possibilità di proroghe).
L’iniziativa è promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali,
Direzione Generale per le Antichità, e dalla Soprintendenza per i Beni
Archeologici dell’Emilia Romagna, in collaborazione con Fondazione Cariparma e
con il contributo del Comune di Parma; il progetto della mostra è di «L’Erma» di
Bretschneider.
L’esposizione ha luogo in tre sale del Palazzo della Pilotta, che vengono
temporaneamente sottratte al normale percorso di visita del Museo per ospitare un
allestimento innovativo ed efficace, che proietta i visitatori nella realtà
della Parma arcaica e di seguito, attraverso i secoli, fino alla fondazione
della colonia e all’avvento della cultura romana.
L’attenzione è rivolta agli aspetti della vita quotidiana in un villaggio
dell’età del Ferro, delle manifestazioni rituali e sacre, delle diverse forme di
sepoltura e dei riti funerari, della formazione della città alle soglie della
romanizzazione
L'esposizione è collegata a tre volumi pubblicati per i tipi della casa
editrice «L’ERMA» di BRETSCHNEIDER, che è anche concessionario unico della
mostra:
Storie della prima Parma. Etruschi, Galli, Romani: le origini della città
alla luce delle nuove scoperte archeologiche, Catalogo della mostra
Storie della prima Parma, Guida breve alla mostra
Parma etrusca, volume di studi miscellanei
Il catalogo è stato realizzato con il contributo della Associazione Nazionale
Costruttori Edili di Parma.
Parma nell’età del Ferro
Una serie di scavi archeologici, condotti dalla Soprintendenza negli
ultimi anni in occasione di lavori di costruzione di edifici moderni, ha
permesso di portare alla luce una fase di vita di Parma finora insospettata,
durata tra la fine del VII ed il V secolo a.C., ancora nella piena età del
Ferro.
I resti archeologici di questa fase portano l’inequivocabile marchio della
civiltà etrusca, comprendendo vasi di bucchero d’impasto, sia di produzione
locale che di importazione dalla Toscana, ceramiche stampigliate e soprattutto
alcune brevi iscrizioni, che dimostrano la presenza etrusca sul posto.
Ma non mancano elementi di confronto con i vicini Liguri e Celti, che provano
come il popolamento della regione fosse di regola misto e una fonte continua di
interscambio culturale.
In quest’epoca non si può parlare propriamente di una città a Parma, ma
piuttosto di una serie di villaggi in posizione ravvicinata, che condividevano e
controllavano un paesaggio comune, dominato dalle acque.
I resti di tali villaggi sono stati rintracciati sia nella periferia
settentrionale (Strada Baganzola, quartiere SPIP, Casalora di Ravadese) sia a
sud (via Saragat) e ad est (S. Pancrazio), a circondare quella che sarebbe stata
la sede della città romana e moderna.
Oltre alle abitazioni, dapprima capanne di pali di legno e poi con zoccolo in
muratura, sono stati ritrovate strutture di produzione della ceramica (fornaci)
e deposizioni rituali di ambito sacro.
Da ultime vanno ricordate le numerose zone di necropoli, con tombe ad
incinerazione entro dolii, che conservavano gli oggetti personali del defunto,
ovvero ad inumazione, in alcuni casi rese monumentali da grandi tumuli circolari
di terra ed evidenziate da cippi di pietra.
La fase celtica
Dopo la fase di popolamento arcaica, durata fino al V secolo a.C., il
sito di Parma non sembra aver avuto uno sviluppo urbano simile a quello di altri
centri dell’Etruria Padana, come ad esempio Bologna, Marzabotto e Mantova.
Al momento attuale, la documentazione raccolta sul popolamento di Parma tra V e
IV secolo è molto sporadica e sembra attestare la riduzione o la scomparsa del
centro abitato riconosciuto nel periodo precedente. Con ogni probabilità su
questa riduzione ha pesato la ridefinizione delle vie commerciali e la
ristrutturazione del territorio conseguente all’avvento della fase urbana, che
nella regione sembra far capo principalmente a Bologna.
Avanzando nel corso del III secolo a.C., le nuove scoperte (specialmente nel
corso degli scavi per la nuova sede della Cassa di Risparmio) sembrano
confermare che il popolamento di Parma abbia conosciuto un rinnovamento, in
forme strutturate che preludono alla città, già prima dell’installazione della
colonia nel 183 a.C.
La romanizzazione
È perciò nel contesto di un centro già formato, che rivitalizzava il
popolamento etrusco di epoca arcaica, che si installano i coloni Romani.
Viene così confermato il resoconto di Tito Livio, che ricorda come “a Modena e a
Parma furono fondate colonie di cittadini Romani, nel territorio che poco prima
era stato dei (Galli) Boi, e prima ancora degli Etruschi”.
Ritrovamenti di eccezionale interesse, a piazzale Ghiaia come a viale Tanara,
gettano luce sui culti e sulle usanze religiose degli abitanti di questa nuova
Parma.
La mostra si chiude con le testimonianze della Parma repubblicana, fino alla
completa romanizzazione, nel contesto della concessione della cittadinanza
romana a tutti gli abitanti della Gallia Cisalpina.
Fra queste merita particolare attenzione un’iscrizione monumentale di Lucio
Mummio, da sempre conservata nel Museo Archeologico Nazionale, che documenta
l’interesse per la città da parte del famoso console, conquistatore di Corinto
nel 146 a.C.
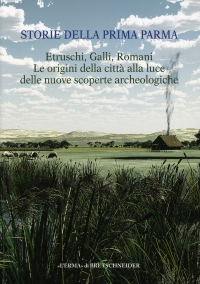 Segreteria organizzativa:
Segreteria organizzativa:
Cristina Longhi (Direzione Generale per le Antichità)
Progetto espositivo:
Tiziana Morana (Direzione Generale per le Antichità)
Maurizio Noè (Direzione Generale per le Antichità)
Grafica:
Gigliola Donadio (Direzione Generale per le
Antichità)
Editoria e ufficio stampa:
«L’Erma» di Bretschneider
Catalogo della mostra:
«L’ERMA» di Bretschneider, Roma 2013 (€ 75,00)
www.lerma.it
lerma@lerma.it
stampato con il contributo di Gruppo
Costruttori Edili - Parma
Guida breve:
stampata con il contributo di Fondazione Cariparma
info Daniela Locatelli tel. 0521 233718 / 282787 (Museo A.N. Parma)
Inaugurazione sabato 12 gennaio 2013,
ore 16.30
presso la Sala dei Busti della Galleria Nazionale al Palazzo della
Pilotta
Strada alla Pilotta, 5 - Parma
intervengono:
Federico Pizzarotti
Sindaco di Parma
dott. Luigi Malnati
Direttore Generale per le Antichità
arch. Carla Di Francesco
Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia
Romagna
prof. Carlo Gabbi
Presidente Fondazione Cariparma
prof. Giuseppe Sassatelli
Ordinario di Etruscologia e Archeologia Italica dell’Università di
Bologna «Alma Mater Studiorum»



