Un progetto espositivo di Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna (MiBACT), C.R.I.F. e Palazzo di Varignana Resort & SPA, in collaborazione con Associazione Culturale Civitas Claterna e IMA, con il patrocinio di Comune di Castel San Pietro Terme e Comune di Ozzano nell'Emilia e con il sostegno economico di C.R.I.F.
CLATERNA
IMMAGINI DI UNA CITTA’ SEPOLTA
L'affascinante racconto della scoperta della città romana di Claterna, sulla Via
Emilia, e la presentazione dello straordinario mosaico pavimentale di una domus
di età imperiale, eccezionalmente esposto a Palazzo di Varignana Resort & SPA
dal 24 giugno 2016 al 30 giugno 2017
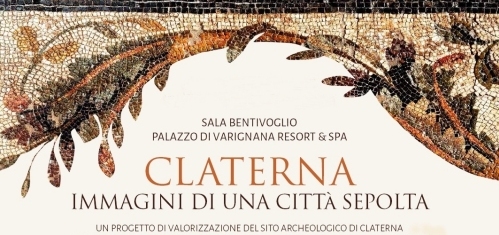
Palazzo di Varignana Resort & SPA
Via Ca' Masino 91
Varignana di Castel San Pietro Terme (BO)
Tel +39 05119938300 - Fax +39 05119938380 -
info@palazzodivarignana.it
La mostra è visitabile ogni
prima e terza domenica del mese dalle ore 9.00 alle ore 11.00
Prenotazione obbligatoria allo 051 19938300 oppure via mail a
marketing@palazzodivarignana.it
 La storia della città romana di Claterna narrata da un testimonial
d’eccezione, un magnifico mosaico policromo proveniente da una domus di età
imperiale, finora esposto al pubblico solo in due occasioni.
La storia della città romana di Claterna narrata da un testimonial
d’eccezione, un magnifico mosaico policromo proveniente da una domus di età
imperiale, finora esposto al pubblico solo in due occasioni.
La mostra che si inaugura il 24 giugno nel Palazzo Bargellini Bentivoglio di
Varignana, sulle colline alle immediate spalle di Claterna, è un ulteriore tassello
nella valorizzazione dell’area archeologica sulla Via Emilia che da 1500 anni
giace sepolta sotto una sottile coltre di terreno nel territorio di Ozzano
nell’Emilia.
L’esposizione dell’incantevole mosaico -uno di rari esempi di tessellato
policromo di età augustea dell’Italia settentrionale-, di oggetti d’uso
quotidiano (vasellame da mensa, balsamari, lucerne) e di altri manufatti che documentano le tecniche costruttive delle
case romane (laterizi, stucchi, intonaci e porzioni di pavimenti in esagonette e
a mosaico), è l’occasione per ripercorrere la vita che scorreva in questa città
in tutti i suoi aspetti, dal vivere al costruire.
L’itinerario proposto restituisce l’idea di un’edilizia abitativa di prestigio e
anche gli oggetti della vita quotidiana esposti in buon numero testimoniano una
sicura agiatezza dei personaggi che qui vissero e che di tale prosperità furono
i protagonisti.
Ci auguriamo che questa esposizione, che vede il coinvolgimento di numerosi
soggetti pubblici e privati, dalla Soprintendenza Archeologia a Palazzo di Varignana Resort & SPA che ospita l’evento, da C.R.I.F. a I.M.A.
all’Associazione Culturale “Civitas Claterna”, possa stimolare e facilitare non
solo negli ospiti del Palazzo di Varignana ma in tutti coloro che vorranno
visitare questo spazio espositivo, un avvicinamento e interessamento al sito
archeologico di Claterna.
Fin dal momento del suo distacco e restauro, il mosaico è stato conservato
nel Museo Civico Archeologico di Bologna e da allora esposto al pubblico solo in
due occasioni: le giornate FAI di Primavera 2014 e la grande mostra “Roma e le
Genti del Po” allestita a Brescia fino al gennaio 2016.
In occasione dell’inaugurazione della mostra (il 24 giugno 2016, ore 16, al
Palazzo di Varignana), Soprintendenza e Associazione Civitas Claterna propongono
per sabato 25 giugno alcune visite guidate all’area archeologica di Claterna
proprio per ribadire lo stretto legame tra gli oggetti esposti e la città da cui
provengono.

Ipotesi ricostruttiva dell'interno della domus dei mosaici
Il mosaico policromo di età
augustea
“Fra i più fini ed eleganti
mosaici policromi di epoca romana”. Così nel 1898 il suo scopritore Edoardo
Brizio definisce la straordinaria fascia musiva policroma rinvenuta a pochi
centimetri di profondità durante gli scavi nell'area di Claterna. Costretto a
riseppellirlo quell'anno stesso, il mosaico è riportato in luce nel 1933 per
volontà dell’allora soprintendente Salvatore Aurigemma che ne affida il distacco
all’Opificio delle Pietre Dure di Firenze per poi esporlo presso il Museo Civico
di Bologna dove però da anni non era più visibile al pubblico. Uscito per
la prima volta dal museo alla volta di Brescia, consolidato e ravvivato nei
colori dal nuovo restauro, si sono create le condizioni ottimali per poterne
rinnovare l’esposizione, riportandolo in una location assai vicina all’antica
città romana.
Realizzato in tessere di Pietra bianca d’Istria, nera di Pistoia e lapidei di vari colori, il Mosaico policromo ora in mostra nel Palazzo di Varignana è di raffinata fattura e singolare suggestione ed è a tutt’oggi la testimonianza più eclatante dell’alto livello di vita raggiunto in età augustea dalla città.
Sulla grande fascia musiva a fondo bianco bordato di nero, si snoda una ricca decorazione policroma con cespo d’acanto centrale, dai cui lati dipartono due coppie di volute fiorite.

Particolare della decorazione policroma del mosaico con l'acanto e le volute
fiorite
Cinque
piccoli volatili multicolori (specie Cutrettola motacilla flava) si
dispongono sul piano e sopra le volute.
L’elaborato motivo vegetale e soprattutto la presenza dei piccoli volatili -motivo iconografico di ascendenza ellenistica, precocemente assimilato e
rielaborato in ambito Urbano- pongono questo mosaico in diretto rapporto con le
produzioni centro italiche più raffinate (da Roma a Pompei) che attraverso la
parte orientale dell’Octava Regio Aemilia raggiungeranno i centri
affacciati più a nord sull’Adriatico, come Altino ed Aquileia. La pluralità di
tali realizzazioni ha fatto ipotizzare specifiche produzioni cisalpine che si
differenziano da quelle Urbane nel gusto di utilizzarle soprattutto in fasce
partizionali e non come cornici accessorie per emblema o pannelli.
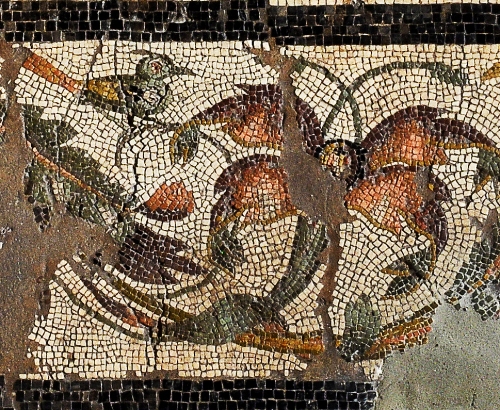
Particolare della decorazione del mosaico con il volatile (Cutrettola) sopra le
volute fiorite
Il mosaico claternate, fra i più antichi esempi noti di tessellatum,
riporta alla seconda metà del I sec. a.C., all’inizio della grande espansione
edilizia tra età augustea e I sec. d. C., periodo in cui si concentra la
maggior parte della produzione musiva di ville rustiche e domus urbane.
Se lo scavo ottocentesco ha messo in luce solo parzialmente la pianta della
domus cui era pertinente, collocata a meno di 30 metri dalla via Emilia, il
tassellatum fitomorfo doveva essere, con ogni evidenza, destinato a
creare una separazione visiva all’interno di un più vasto vano tra settori di
diverso impegno decorativo tra cui si distingue, per originalità, la partizione
a sud, caratterizzata da un mosaico bianco e nero con effetto a cancellum,
marginato da un complesso motivo a meandro.
La raffinata composizione di questo pavimento così come gli eleganti pavimenti
in opus signinum di età repubblicana che stanno emergendo dagli scavi più
recenti dimostrano la grande vitalità della città anche prima della nascita di
Claterna, che propone la propria origine etrusca già dal nome.
L'esposizione del mosaico policromo, oltre a riaccendere i riflettori sul documento che per primo aveva rivelato l’elevato tenore di vita della città in epoca augustea, vuole poter confrontare questa testimonianza musiva con gli altri tessellati estremamente raffinati, seppur di tipo geometrico e bicromatici, restituiti dagli scavi degli ultimi anni nella Casa dei Mosaici .

Se la fascia con tralci d’acanto spicca per eccezionalità, va comunque inserita
nel quadro generale costituito anche da altri tessellati di gran pregio e dagli
articolati impianti planimetrici delle domus individuate nella parte
meridionale di Claterna, per comporre l’immagine di una città caratterizzata da
evidenti e diretti richiami all’ambito Urbano.
L’antica città godette di un prestigio del tutto particolare certo dovuto al suo
favorevole posizionamento sulla via Emilia, alla confluenza con lo sbocco in
pianura del Quaderna, ma anche da motivazioni di ordine politico. Grazie al
sostegno fornito sul nascere alla politica augustea -e al conseguente
particolare favore conquistato presso Augusto e tradotto negli usi di una
speciale pietas, spesso legata alla figura del potentissimo Agrippa,
comandante e genero dell’imperatore- Claterna potè entrare in una dimensione
storica di ampio respiro.
I documenti archeologici che attestano un significativo rapporto con
Augusto sono numerosi. I più recenti -fra cui spicca per eccezionalità la
gemma di rara iconografia nella quale i Parti sono inginocchiati ai piedi della
vittoria di Augusto- si affiancano a quelli noti da tempo, come la stele
funeraria che attesta la presenza nella città di un seviro augustale, magistrato
addetto al culto della famiglia imperiale.
E se non sono prive di significato le
evidenti somiglianze planimetriche e nei tipi dei tessellati riscontrabili fra
la domus del seviro augustale di Ercolano e la Domus dei mosaici
di Claterna, si potrebbe ipotizzare che quest’ultima sia stata la dimora
del magistrato claternate.
Questi organizzò spettacoli nell’antica città, certamente in un luogo a questi
dedicato, fortemente evocato dal recente ritrovamento, nella parte sud
orientale, della testina in marmo del “giovane” della commedia latina, anch'essa
esposta in questa mostra.
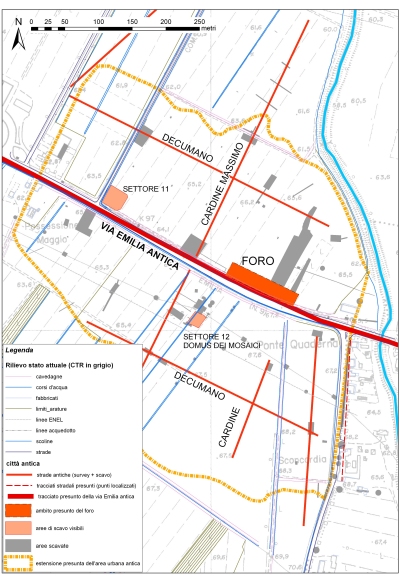 Claterna, città ‘sepolta’ ubicata tra Bologna e Imola, nel
territorio di Ozzano dell’Emilia, nasce nel II secolo a.C. La sua funzione
iniziale è duplice: la città è sia un importante snodo viario (all’incrocio fra
via Emilia, torrente Quaderna e una via transappenninica, forse la Flaminia
minor), sia un centro di servizi e mercato.
Claterna, città ‘sepolta’ ubicata tra Bologna e Imola, nel
territorio di Ozzano dell’Emilia, nasce nel II secolo a.C. La sua funzione
iniziale è duplice: la città è sia un importante snodo viario (all’incrocio fra
via Emilia, torrente Quaderna e una via transappenninica, forse la Flaminia
minor), sia un centro di servizi e mercato.
Nel I secolo a.C. Claterna, come tante altre città italiche, diventa un
municipium con competenza sul vasto territorio compreso fra i torrenti Idice
e Sillaro.
La città ha la forma di un trapezio irregolare (m. 600x300) che si sviluppa ai
lati della via Emilia delimitata ad ovest dal rio Gorgara e ad est dal torrente
Quaderna; nel momento di massima espansione urbanistica occupa una superficie di
circa 18 ettari.
L’asse ordinatore del sistema stradale è rappresentato dalla via Emilia (decumanus
maximus) che nel centro dell’abitato incrocia quasi ortogonalmente un asse
interpretabile come cardo maximus; le strade minori seguono generalmente
questo che coincide esattamente con quello della centuriazione claternate. Nel
settore sud-est le tracce viarie e infrastrutturali assumono invece orientamenti
di tipo astronomico da nord a sud, considerati indizio di una maggiore antichità
rispetto al resto dell’abitato.
I lastricati stradali, compreso quello della via Emilia, sono generalmente in
ciottoli e ghiaia mentre nei tratti di maggior importanza le pavimentazioni sono
ottenute con grandi scaglie di pietra accuratamente incastrate tra loro. In
prossimità dell’incrocio fra cardo e decumanus maximi si imposta l’area
forense, un ampio spiazzo acciottolato vero e proprio ‘cuore’ di Claterna su cui
si affacciano i principali edifici politici, religiosi, economici ed
amministrativi.
Grande importanza ed estensione hanno anche i suburbia, lungo le strade
principali, dove sono collocate sia le attività artigianali che le necropoli.
Le abitazioni private -distribuite all’interno degli isolati cittadini-
si sviluppano su ampi spazi ed sono caratterizzate dalla presenza di numerosi
ambienti, spesso di notevoli dimensioni, prospettanti su cortili e giardini. La
maggior parte delle stanze aveva pareti affrescate e pavimenti in cocciopesto o
a mosaico.
La tipologia più diffusa nel mondo romano (a partire dall’età repubblicana),
presente anche nella regione VIII Aemilia, è la casa con corte centrale, intorno
alla quale si distribuiscono alcune stanze (cubicula); in fondo all’atrio
è collocato l’ambiente principale, il tablinum, affiancato da uno o due
vani minori e da un corridoio che porta all’orto-giardino, collocato alle spalle
della casa.
Le abitazioni avevano generalmente un accesso dalla strada e molto raramente
erano provviste di un secondo piano. In alcuni casi si riconoscono anche
ambienti di servizio, cucine che affacciano su piccoli cortili interni o
taberne collocate sul fronte stradale.
Con il passare dei secoli gli edifici assumono una pianta più articolata e
complessa, caratterizzata da ampie aree scoperte provviste di porticati, grandi
ambienti di rappresentanza, alcuni dotati di riscaldamento.
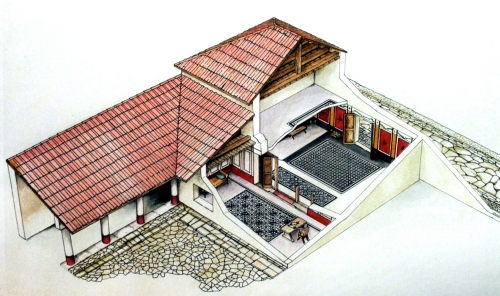
Ricostruzione grafica di una domus romana
La conoscenza delle tecniche edilizie impiegate in età romana si basa sia
su fonti scritte che sull’analisi di quanto resta delle strutture rinvenute nel
corso degli scavi. Per gli edifici privati è stato possibile riconoscere
l’impiego di tecniche caratterizzate dalla semplicità di esecuzione e spesso
dall’uso di materiale di facile approvvigionamento anche se più facilmente
deteriorabile.
Nella maggior parte delle domus le fondazioni e la prima parte delle
murature fuori terra venivano realizzate con frammenti di tegole e mattoni,
cotti in apposite fornaci; il resto delle pareti era formato da mattoni in
argilla cruda oppure costruito con tecnica a telaio, composta da un’orditura
interna di assi e travetti disposti in verticale, orizzontale e obliquo,
collegati ad incastro tra loro e tamponati con ramaglie, tutto quanto rivestito
da uno spesso strato di argilla cruda impastata.
Nella copertura degli edifici veniva utilizzato sia il legno sia il laterizio,
tegole e coppi, mentre per i pavimenti degli ambienti di rappresentanza era
previsto l’impiego del mosaico.
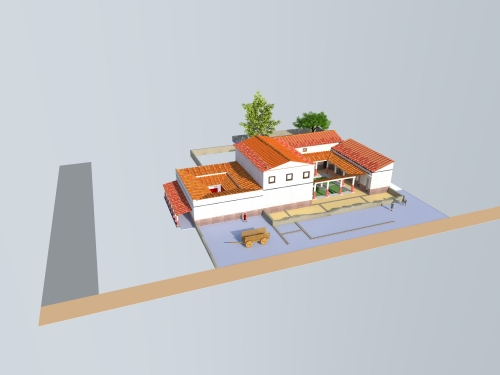
Ipotesi ricostruttiva della domus dei mosaici di Claterna
In tutte le case di Claterna c'erano servizi da tavola comprendenti coppe,
piatti, bicchieri, bottiglie e brocche.
I vasi erano principalmente di ceramica, di forme e colori diversi a seconda
delle epoche. In età imperiale, dalla fine del I secolo a.C., divennero di moda
i piatti e le coppe in ‘terra sigillata’, ceramica dalla caratteristica
colorazione rossa, spesso timbrata con il marchio del fabbricante.
La mensa era inoltre arricchita da recipienti in vetro, spesso multicolori, e
non mancava il più prezioso vasellame bronzeo; nelle case dei più ricchi erano
presenti argenterie riccamente decorate.
Grande importanza ebbero anche le ceramiche comuni, adatte sia alla
conservazione dei cibi che alla loro cottura (ceramiche da fuoco). In cucina si
usavano anche macine manuali e mortai in pietra, che potevano servire sia per la
preparazione dei cibi, sia per la creazione di sostanze medicamentose ed essenze
profumate.
I vari aspetti della vita quotidiana sono esemplificati da oggetti in materiali
diversi: vetro e paste vitree, avorio ed osso, metalli, ceramica. Come strumenti
per scrivere, ad esempio, erano utilizzati gli stili in osso con cui si
scrivevano lettere e documenti sulle tavolette cerate mentre per il gioco si
usavano soprattutto dalle pedine circolari in paste vitree e in pietra. Erano
molti i giochi ‘di società’ praticati, dal più semplice ‘tris’ al più complicato
ludus latrunculorum.
Oggetti fondamentali in casa erano poi le lucerne, spesso uniche fonti di
illuminazione, che infatti troviamo in grande numero e tipologia. Tramite uno
stoppino, bruciavano l'olio che veniva introdotto nell’apposito serbatoio.

La porzione di vetrina riservata alle lucerne rinvenute a Claterna
I Romani avevano approntato una vera e propria rete di servizi, strade e rotte
marittime che permetteva di assicurare merci e rifornimenti sia al mercato che
ai diversi apparati dello Stato. Particolarmente prosperoso era il commercio
dell’olio e del vino effettuato utilizzando i contenitori da trasporto per
eccellenza, cioè le anfore. In tutta Italia la produzione di questi oggetti fu
intensissima come attestano, almeno fino al II-III secolo d.C., la diffusione di
particolari tipi di anfore di produzione soprattutto ‘adriatica’ (Istria,
Veneto, Emilia, Marche, Puglia), spesso marcate con il nome del produttore.
Durante l’età imperiale e fino alla tarda antichità ebbero poi grande impulso le
produzioni olearie delle province ispaniche, galliche e africane che esportavano
in tutta Europa e in tutto il Mediterraneo.
Il commercio riguardava comunque oggetti e merci di tutti i tipi. Tra i
numerosissimi esempi di articoli commercializzati vanno posti i ‘balsamari’ (di
vetro e di ceramica), piccoli flaconi contenenti medicinali e profumi.
La città di Claterna, dopo un floruit collocabile nella prima età imperiale, sopravvive fino alla tarda antichità (V-VI secolo d.C.), seppure
notevolmente ridimensionata.
Interviene poi la fase di abbandono fino al completo oblio.

La vetrina dedicata agli elementi architettonici e ai materiali da costruzione
Fin dall’800, l’antica città romana di Claterna è stata un campo d’indagine
privilegiato per l’archeologia emiliano-romagnola. Qui hanno scavato i massimi
protagonisti dell’archeologia regionale (da Edoardo Brizio a Guido Achille
Mansuelli) con interventi sporadici ma di notevole rilievo.
L’unicità di Claterna è dovuta al fatto di non aver avuto una continuità storica
analoga a quella degli altri centri -da Rimini a Piacenza- sorti lungo la via
Emilia e in qualche caso preesistenti ad essa. Claterna ha quindi offerto la
possibilità di indagare una città romana nella sua estensione e configurazione
interna senza le modifiche intervenute nel tempo, dal Medioevo ai giorni nostri.
Purtroppo il livello di alluvionamento che ha ricoperto i resti romani non è
stato sufficiente a garantire la protezione degli alzati degli edifici, sicché
si è potuto recuperare soprattutto piani pavimentali e stradali e modeste
porzioni dei muri perimetrali.
A partire dagli anni 80 -grazie all’opera di Jacopo Ortalli che ha proceduto a
una serie di indagini più sistematiche- la Soprintendenza ha intrapreso la progressiva
acquisizione dell’ampia superficie su cui si estende l’antica città romana
mentre dal 2005, con la costituzione dell’Associazione Civitas Claterna, si è
dato vita a un grande progetto di studio e valorizzazione tra associazione,
Comune di Ozzano Emilia e Soprintendenza Archeologia.
Due gli obiettivi degli scavi ancora in corso. Da un lato chiarire alcuni
aspetti topografici (i suoi limiti, l’articolazione interna, gli spazi pubblici
e sacri quali foro, basilica, edifici templari e teatro) e cronologici (dalla
fondazione e dall’eventuale origine preromana al declino) dell’antica città,
dall’altro valorizzare alcuni spazi per consentire al pubblico di visitare le
evidenze archeologiche più suggestive, come la Casa del fabbro e la Domus dei
mosaici.
Dalla foto aerea risultano evidenti le tracce di edifici pubblici
Claterna. Immagini di una città sepolta
Promotori: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo,
Soprintendenza Archeologia dell’Emilia Romagna, C.R.I.F. Centro Ricerche
Informazioni Finanziarie S.p.A., Palazzo di Varignana Resort & SPA, in
collaborazione con Associazione Civitas Claterna
Coordinamento e progetto scientifico: Renata Curina, Soprintendenza
Archeologia dell’Emilia-Romagna, Paola Desantis, Polo Museale
dell'Emilia-Romagna, Claudio Negrelli, Università Ca' Foscari - Venezia, Studio
Saura Sermenghi
Progetto espositivo: Renata Curina, SAR-ERO, Studio Saura Sermenghi,
Maurizio Molinari
Allestimento:
Studio Saura Sermenghi
Testi dei pannelli e guida:
Renata Curina, Paola Desantis, Claudio Negrelli
Restauri:
Michela Bortolotti
Modelli ricostruttivi 3D:
Paolo Nanni
Illustrazioni ricostruttive:
Claudio Negrelli
Foto di scavo:
Archivio Soprintendenza Archeologia (Roberto Macrì)
Foto aeree e dei reperti:
Maurizio Molinari
INAUGURAZIONE A INVITO VENERDÌ
24 GIUGNO 2016, ALLE ORE 16,
NELLA
SALA BENTIVOGLIO DEL PALAZZO DI VARIGNANA RESORT & SPA
Segue cocktail ispirato alla cultura e cucina d'epoca romana
RSVP entro il 21/06/2016
+39 051 273861 – EVENTI@LABIDEE.IT
Eventi e iniziative collegate alla mostra
Dall'8 al 16 luglio 2016, III edizione del
Varignana Music Festival
Visite guidate gratuite agli scavi
archeologici di Claterna -Domus dei mosaici e Casa del Fabbro- a cura dei
volontari dell'Associazione Civitas Claterna e degli archeologi della
Soprintendenza:
Domenica 10 luglio 2016, ore 10, Sabato 16 luglio 2016, ore 16 e
Domenica 24 luglio 2016, ore 10
Ritrovo alla cosiddetta “Casa Gialla” in
Via Emilia 482-484, località Maggio di Ozzano
dell’Emilia (BO)
Palazzo di Varignana Resort & SPA è un’elegante villa del ‘700 adagiata nello scenario della campagna emiliana. Restituita all'originario splendore grazie a un sapiente restauro, è oggi un’esclusiva location per relax o momenti di lavoro.
